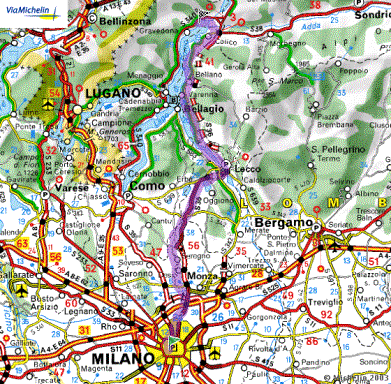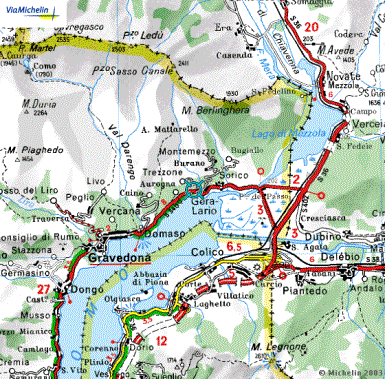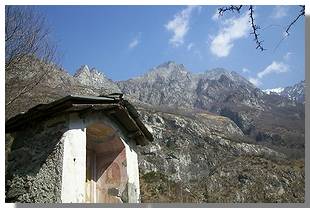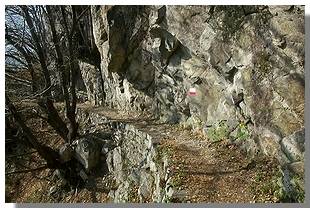|

|
Sabato e
Domenica 8/9 Maggio
UN WEEK END TRA VELA E MONTI
E’ un miscuglio inusuale, ma con un
certo fascino: la vela e le passeggiate in montagna, mescolate con
significativi spunti culturali.
Nell’alto lago di Como (Colico) c’è la
possibilità di un week end che possiamo definire
velico/camminereccio/culturale. Possiamo organizzare il pernottamento presso
un’ostello che gi garantirà pernottamento e cena in riva al lago. C’è un
circolo velico a Gera Lario che permetterà a chi vuole di fare una giornata
in vela in un luogo che sembra fatto apposta. Vicino c’è l’Abbazia di Piona
che è una delizia per gli occhi e lo spirito. Per non parlare poi dei
sentieri montani locali, al di fuori del solito giro dei milanesi. Un week
end da non dimenticare.
Per i più appassionati
di vela prevediamo di noleggiare una barca per l’intera giornata, mentre per
i neofiti che hanno qualche perplessità di stare in barca per una giornata,
prevediamo una iniziazione più adeguata
C’ la festa
dell’Officina del Vento che celebra i suoi 10 anni di attività, Chi vorrà
potrà inserirsi nel suo piano di attività, con anche visite guidate, gare di
modellini ed attività varie.
Possibilità di vela
Uscita per neofiti con
minicorso alla domenica 5€ a testa
Noleggio di una barca
per l’intera giornata con uno di noi a fare da skipper – circa 90€ da
dividere circa in 9 persone in due turni di mezza giornata (da un minimo di
10€ a testa, ad un massimo di 18€ a testa per chi vuole fare l’intera
giornata)
Possibilità di iscrizione
al club per 28€ a testa con diritto ad una uscita in barca
Possibilità di
passeggiate, si sceglieranno quelle che si preferiscono
Da Concilio di Rumo a
Sorico (lungo costa)
Alla chiesa di San Miro,
con il giro delle 3 chiese
La valle del Liro
I Piani di Spagna (Forte
Fuentes)
L’Abbazia di Piona
(cercheremo di andarci in barca)
Camminata in Val Codera
E’ importante
prenotarsi, specificando, per quanto riguarda la vela, se fare solo l’uscita
di domenica, o mezza giornata o la giornata. Se siete esperti, ditecelo.
Riferimento Tina:
tina.a@iol.it
Tel 349-3532282
Oppure a Guido Platania
Tel 335/208784 - gp@helponline
.it
|
Programma di massima
Mezzi, pensiamo di andare in macchina con suddividione
delle spese, ma ci sono ottimi treni che fanno Milano-Colico e poi possiamo
venire a prendere alla stazione quelli che vengono in treno
Sabato
8.30 Partenza da Milano
10.30 – a Gera Lario, i velisti
montano in barca per la giornata, gli altri girano per le cose più
interessanti da vedere. Giri da definire
18.30 All’ostello ci si prepara per
la cena
Domenica
9.30 I neofiti si trovano per il
mini corso e l’uscita in barca, gli altri in giro
12.30 – Da definire
18.30 Incomincia il triste ritorno
Spesa
prevista –
Macchina per andata e
ritorno ed eventuali spostamenti interni, da dividersi tra i passeggeri
Mezza pensione
all’ostello, compreso vino ed acqua (una base) a cena 20 euro
Uscita in vela di domenica
circa 5 euro
Noleggio barca di sabato 1
giornata, circa 90 euro da suddividersi (mezza giornata circa 10 euro a
testa, l’intera giornata 18 euro a testa)
|
|
|
|
|
|
|
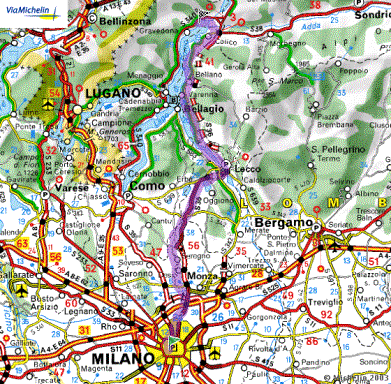
|
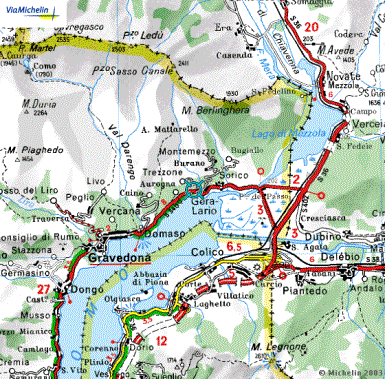
|
Gera Lario

Piccolo centro
all’estremità della sponda occidentale dell’Alto Lario, si trova allo sbocco
del torrente Gera e ai piedi del Montemezzo.
Oggi è una delle mete turistiche preferite dagli appassionati di sport
lacuali. A supporto di queste attività esistono moderne strutture private e
pubbliche tra le quali il nuovo lido e il nuovo porto.
 
Si ipotizza che
il nome “Gera” derivi dalla parola greca “leréus”, sacerdote, ad indicare la
presenza di un luogo di culto.
Questo paese fu fondato nelle vicinanze di Olonio e utilizzato dalle truppe
spagnole come base durante gli scontri con i Grigioni di Valtellina. Il
paese, nel 1482, ottenne dalla Pieve di Sorico l’autonomia ecclesiastica.
Seguì le vicende del feudo delle Tre Pieve, successivamente contea di Tolomeo
Gallio (1580) fino a che, nel 1620, durante il dominio spagnolo, raggiunse
anche l’autonomia amministrativa.
 Sulle case, affacciate
all’unica piazza allungata lungo la Strada Regina ed ombreggiata da secolari
platani, rimangono numerosi affreschi sacri dei secoli XVI e XVII a testimonianza
dei periodi prosperi che gli abitanti del posto hanno avuto modo di vivere. Sulle case, affacciate
all’unica piazza allungata lungo la Strada Regina ed ombreggiata da secolari
platani, rimangono numerosi affreschi sacri dei secoli XVI e XVII a testimonianza
dei periodi prosperi che gli abitanti del posto hanno avuto modo di vivere.
In questo comune vi nacquero due personaggi famosi, Giorgio Giulini,
scrittore del 700 di storia milanese, e il pittore Luigi Fontana.
Da visitare:
Chiesa di San
Vincenzo
 La chiesa romanica di San
Vincenzo fu eretta a cavallo dei secoli XI e XII a fianco dell’omonimo
torrente, proprio dove un tempo sorgeva una villa romana e ricostruita nel
Quattrocento. La chiesa romanica di San
Vincenzo fu eretta a cavallo dei secoli XI e XII a fianco dell’omonimo
torrente, proprio dove un tempo sorgeva una villa romana e ricostruita nel
Quattrocento.
Sullo stipite sinistro del portale vi è murata una lapide romana, del III o
del IV secolo, sulla quale i genitori ricordano il bimbo “dolcissimo e
desideratissimo”.
Durante i lavori
di restauro effettuati nel 1964/65, sono stati scoperti, sotto l’abside, un
mosaico pavimentale risalente al II secolo e le fondamenta della prima
chiesa.
La facciata a capanna è coronata di archetti in cotto ed è preceduta da un
pronao, è aperta da due monofore, da due finestre e da un occhio anch’esse
corniciate in cotto.
L’interno della chiesa, di gusto rinascimentale, comprende, oltre agli
stupendi affreschi della volta raffigurante gli Evangelisti, un Polittico
dell’altare maggiore datato 1547 raffigurante le scene della Crocifissione e
della Madonna col Bambino ed altro con intagli, statue e dorature, di poco
posteriori
Santuario Nostra
Signora di Fatima
 Edificata nel 1634 in
centro del paese per rendere più comoda la partecipazione della popolazione
alle funzioni religiose. Edificata nel 1634 in
centro del paese per rendere più comoda la partecipazione della popolazione
alle funzioni religiose.
Fu decorata con il contributo dei pescatori che versavano il guadagno della
pesca effettuata nei giorni festivi.
L'edificio venne invaso dal fango e gravemente danneggiato dalla tragica
alluvione dell'8 agosto 1951 che provocò la morte di 17 geresi. Ristrutturata
dopo dieci anni di lavoro, fu consacrata nel 1963 dal Vescovo di Como Felice
Bonomini come "Santuario dei pescatori". Successivamente il
Santuario venne visitato dal Vescovo di Fatima, Venancio Pereira, che
consacrò i due altari laterali dando inizio ad un gemellaggio spirituale tra
Gera e Fatima. Nel Santuario, ora meta di pellegrinaggi e d'incontri, è
conservata un'effigie della Vergine proveniente da Fatima e benedetta a Roma
in San Pietro nel 1959 da Papa Giovanni XXIII.

 Qualche numero: Qualche numero:
Superficie:
6,670 kmq.
Altitudine: m. 201
Popolazione: 913
Densità abitativa: 136,882
Cap: 22010
|
|
L’ABBAZIA DI PIONA

Fiore all'occhiello del paese di
Colico è l'abbazia di Piona, che però si trova in frazione Olgiasca, sul
promontorio roccioso che degrada verso il laghetto semichiuso formato da una
strozzatura naturale.
 Venne
fondata dai Cluniacensi attorno alla chiesa di San Nicolao, costruita sui
resti di un oratorio edificato dal vescovo di Como Agrippino nel VII
secolo. Venne
fondata dai Cluniacensi attorno alla chiesa di San Nicolao, costruita sui
resti di un oratorio edificato dal vescovo di Como Agrippino nel VII
secolo.
Fu trasformata in commenda
secolare, soppressa nel Settecento e restaurata all'¡nizio del nostro secolo,
ed è attualmente di proprietà dei cistercensi dell'abbazia laziale di
Casamari.
 La
chiesa, dell'Xl secolo, è a pianta irregolare, ad una sola navata con
soffitto ligneo, e conserva due leoni in marmo dell'antico protiro e
frammenti di affreschi del Duecento legati alla tradizione bizantina. La
chiesa, dell'Xl secolo, è a pianta irregolare, ad una sola navata con
soffitto ligneo, e conserva due leoni in marmo dell'antico protiro e
frammenti di affreschi del Duecento legati alla tradizione bizantina.
E’ affiancata da un campanile
ricostruito nel Settecento e da un bellissimo chiostro del 1257, in cui si
sovrappongono motivi architettonici romanici e gotici ed influenze
d'oltralpe. Gli affreschi delle pareti richiamano il linguaggio figurativo
bizantineggiante dei dipinti all'interno dell'abbazia.
 Caratteristico
è il raro soggetto dell'affresco di un calendario figurato, di stile primo
gotico, con immagini di santi ed episodi di vita contadina legati ai mesi
dell'anno. Le quaranta colonnine e i quattro piloni portanti terminano con
capitelli scolpiti ciascuno in modo diverso dall'altro. Caratteristico
è il raro soggetto dell'affresco di un calendario figurato, di stile primo
gotico, con immagini di santi ed episodi di vita contadina legati ai mesi
dell'anno. Le quaranta colonnine e i quattro piloni portanti terminano con
capitelli scolpiti ciascuno in modo diverso dall'altro.
La storia.
«Gioiello del
romanico lombardo», così Federico Farina sottotitola la sua guida
storico-artistica (Edizioni dell'Abbazia) dedicata all'abbazia di Piona, e
proprio di un gioiello si tratta nonostante le vicissitudini della sua
storia.
Posta sulla radura della collina di Olgiasca,
nella parte nord di «quella sponda del lago di Como che volge ad oriente», si
protende verso le cittadine di Dongo e Gravedona, sull'altra riva del lago,
quasi a volerle incontrare.
La prima documentazione storica della presenza di
una comunità monastica in questa terra è costituita da un cippo fatto
scolpire dal vescovo di Como Agrippino (607-617) nel decimo anno del suo
mandato, nel quale si ricorda l'erezione e la dedicazione di un oratorio
dedicato a santa Giustina martire. Conferma dell'esistenza di tale edificio
ci viene dal Tatti il quale, nell'elencare i monasteri della diocesi,
afferma, senza citare la fonte, che nell'824 il primo monastero che si
incontrava sorgeva a Piona e portava il nome di santa Giustina. Di questo
edificio resta una piccola abside posta in posizione rialzata poco discosta
dal livello dell'attuale chiesa.
Alla fine del secolo XI, Piona fu inserita nel
movimento della riforma cluniacense. Non esiste più l'atto ufficiale di
adesione, ma dall'analisi dei documenti di altri priorati cluniacensi della
zona, San Pietro di Vallate (1107), San Giovanni Battista di Vertemate (1084)
e San Nicola di Figine (1107), si può asserire che anche la comunità
monastica di Piona sia entrata nel movimento di riforma in quel periodo.
Pochi sono i documenti giunti fino a noi relativi
a quel periodo di storia dell'abbazia, ma sufficienti a tracciare la parabola
della vita che vi si svolgeva. Il più interessante è un documento della metà
del XIII secolo in cui si menziona una tassa di 13 lire imperiali riscossa da
Guglielmo da Lenora visitatore della casa madre di Cluny; in un altro
documento del 1277 è attestata la presenza di otto monaci che osservavano
regolarmente la regola monastica.
Tuttavia, il documento più importante è costituito
dalla struttura stessa del monastero; infatti l'adesione alla riforma
cluniacense non solo comportava l'invio di un folto numero di monaci dalla
casa madre, ma anche una concezione nuova del monachesimo che si
concretizzava in una disposizione delle strutture disposte in modo armonico e
funzionale intorno al chiostro, che diventava punto di riferimento ideale
della pianta e perno intorno a qui ruotava tutta la struttura.
Gli studiosi ipotizzano che i monaci di Piona
siano intervenuti sull'oratorio di Santa Giustina in attesa della nuova
chiesa che diverrà, secondo una prassi documentata, la prima delle quattro
ali del monastero ad essere realizzata.
Dopo l'adesione al movimento della riforma
cluniacense il monastero di Piona fu dedicato alla beata Vergine Maria e,
sedici anni dopo, viene indicato come Ecclesia sancti Nicolai.
Il Giussani riferisce che nel 1906, mentre erano
in corso i primi interventi di restauro della chiesa, venne alla luce
un'iscrizione, oggi quasi totalmente illeggibile, con la data del 1138 come
anno di consacrazione alla beata Vergine da parte del vescovo Ardizzone di
Como, ma non si è in grado di stabilire se la dedica a san Nicola di Bari
quale co-patrono, culto che tra l'altro è largamente attestato in zona in
quanto protettore dei naviganti, avvenne in quella occasione o in un momento
successivo. Certamente nel 1154 era già attestata la dedicazione, così come
si ricava da un documento di vendita in cui si afferma «a mane sancti Nicolai
de Piona».
Nel corso del XIV secolo cominciarono ad affiorare
i primi sintomi di una decadenza alla quale la casa madre di Cluny tentò di
porre rimedio con l'invio di sussidi in denaro per far fronte alla
manutenzione dei fabbricati e al ripianamento dei debiti, e monaci per
rinsanguare la comunità.
Nel XV secolo la situazione continuò a peggiorare.
Da un documento del 1432, rinvenuto dal Giussano nell'archivio comunale di
Como, risulta che, alla morte del priore Imblavado de' Caimi, ultimo monaco
rimasto a Piona, il duca di Milano Filippo Visconti nominò, con atto del 20
febbraio 1432, un tale Stefano Castello quale amministratore economo dei beni
del priorato.
Questa amministrazione provvisoria a Piona si
protrasse per tre secoli provocando guasti che vengono più volte descritti
nelle visite pastorali che si susseguirono dopo il concilio di Trento.
In queste visite l'antico priorato cluniacense
viene descritto in uno stato di estrema povertà e di assoluto abbandono;
significativi sono gli atti della seconda visita pastorale del vescovo di
Como Feliciano Ninguarda, del 7 novembre 1593, dove si lamenta che "nel
cimitero vi entrano bestie e le campane stanno per cascare".
A seguito della legge del 19 florile anno VI della
Repubblica Cisalpina (8 maggio 1798 del nostro calendario) il Direttorio
incamerava tutte le abbazie con decreto del 14 pratile (2 giugno).
Con atto notarile dell'11 aprile 1801 i fondi
dell'ex priorato di Piona furono assegnati al cittadino grigionese Salis
Tagstein. Dal Tagstein la proprietà passò alla famiglia Sacchi di Gravedona,
poi ai Genazzini di Bellagio, quindi ai Pezoni e ai Casati di Gravedona,
infine, nel 1904, alla signora Angela Rizzi in Secondi.
Il risveglio d'interesse per il patrimonio
culturale che caratterizzò il 1800, attirò l'attenzione anche su Piona, che
fu interessata da una serie di restauri che, pur tamponando i malesseri del
tempo e dell'incuria, non riuscirono a restituire all'antico priorato la
vitalità che lo aveva distinto nei suoi primi anni di vita. La sua vita
sarebbe rinata da una terribile sciagura.
Il 12 novembre 1935 il commendatore Pietro Rocca,
esponente di una famiglia imprenditoriale, acquisì la proprietà del monastero;
il fratello di lui, Cesare, aveva ottenuto l'affidamento della costruzione di
un tratto di strada in Etiopia, nella zona di Fil-Fil. In seguito il cantiere
fu trasferito a Mai-Lalà, a poche centinaia di metri dalla prima linea dove
allora era attestato il fronte italiano durante la campagna etiopica.
Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio l'esercito
etiopico compì una sortita nel cantiere uccidendo, tra gli altri, Cesare
Rocca e la moglie Lidia Maffioli.
Dopo questa tragedia, il fratello Pietro e la
madre Annetta Pogliani, per ricordare il sacrificio di Lidia e Cesare,
decisero di affidare il monastero di Piona alla Congregazione di Casamari
quale segno di purificazione e di perdono; gesto tangibile di superamento di
ogni inimicizia.
Il 13 febbraio
1938, a due anni esatti dal massacro di Mai-Lalà, un gruppo di monaci
provenienti da Calamari prese possesso dell'abbazia di Piona non solo
riaprendola «al culto e offrendo ai turisti un'altra squisita testimonianza
di un'arte lombarda, ma dando a Piona una vita feconda di bene».
|
|
TRA S.VINCENZO E SAN MIRO
Riprende, con questa bella gita, la nostra
esplorazione dei piccoli paesi che s'affacciano sulle sponde del Lago di Como
e che, senza un ordine preciso, ci porterà a visitarli quasi tutti.
La nostra nuova meta si trova al vertice
settentrionale del bacino lariano, sulla sua sponda Ovest. Ci muoveremo fra i
paesi di Gera Lario e di Sorico che sorgono nel punto in cui il fiume Mera,
proveniente dalla Valchiavenna, entra largo e placido nel lago, fondendosi
silenziosamente con le sue acque. Per quanto incessantemente disturbati dal
traffico che scorre intenso sull'angusta Statale, abbiamo scoperto che, fatti
pochi passi, si può abbandonare il caotico nastro d'asfalto per immergersi in
una dimensione più a misura d'uomo.
Gera e Sorico sorgono su due depositi alluvionali
uniti a formare un'unica striscia di terra che s'affaccia sullo sbocco del
fiume Mera nel lago. Alle spalle degli abitati la montagna si alza subito
ripida e culmina molto più in alto, oltre i 2000 metri, con la cima del Sasso
Canale. Sulla sponda opposta del Mera si stendono le vaste pianure palustri
del Piano di Spagna, Oasi Protetta della Regione Lombardia.
Oltre ai numerosi motivi d'interesse che offre, la
passeggiata ha una sua peculiarità: può essere fatta anche sfruttando il
traghetto. Si potrà, quindi, partire da uno dei tanti porti lariani e
dirigersi verso l'attracco di Gera Lario, arricchendo l'esperienza con le
splendide panoramiche che si godono dalla nave.
A Gera, antichissimo borgo già abitato in epoca
romana, come testimonia una lapide del II secolo (oggi conservata al Museo
Archeologico di Como), si può arrivare anche con l'auto. Basta percorrere la
carrozzabile della sponda occidentale del Lario oppure la più veloce
Superstrada 36, che da Lecco raggiunge Colico da dove si prosegue brevemente
verso Chiavenna per poi volgere a sinistra e puntare verso Como.
Il percorso ha come suoi punti estremi le antiche
chiese di San Vincenzo e di San Miro che sorgono sull'originario percorso
della strada romana detta "Strada Regina". Otre alle attrattive
storiche e artistiche, l'area della foce del Mera offre alcuni spunti
d'interesse ambientale e paesaggistico. Unico neo che ci sentiamo di
segnalare è la constatazione di come tali bellezze siano veramente poco
valorizzate. In alcuni tratti, specie al margine della Statale, la strada
versa in cattive condizioni di pulizia: spesso se ne incontrano tratti che
mostrano la completa assenza di manutenzione. È un vero peccato perché
basterebbe un po' più di cura e di attenzione per i particolari a rendere
questa escursione veramente indimenticabile.
Percorso
Dal porticciolo di Gera
Lario si segue il camminamento lungo lago che porta verso Sud-ovest
(direzione Dongo) e, lambendo alcune ville, arriva in breve sulle sponde del
torrente che scende dalla Val di Gera, poco a monte della sua foce. Si
risale, a destra, un sentierino nel prato che ben presto prosegue con un
moderno camminamento lastricato, inizialmente un po' sconnesso. Si giunge
così, in pochi passi, alla Statale; sul ciglio della strada si piega a
sinistra oltrepassando il torrente grazie ad un ponte, mentre sul lato
opposto è già visibile la chiesa di San Vincenzo. Traversata la strada si
giunge sul sagrato della chiesa fra le cui aiuole sorge una statua dedicata a
Padre Pio. Un bel viale acciottolato, fiancheggiato da cipressi, porta
davanti alla soglia dell'edificio, protetta da un portichetto sostenuto da
due colonne di pietra, sopra il quale si trova un finestrone circolare. Anche
ad un occhio profano, la semplice, bianca facciata indica che la chiesa è
stata oggetto di diversi interventi succedutisi nel tempo. In effetti, scavi
effettuati nel 1964-65 mostrarono l'esistenza di un edificio sacro romanico,
sulle cui mura fu innalzata la nuova chiesa (le sue prime notizie certe
risalgono al 1176).
Ma altre tracce del remoto passato di questa
chiesa sono ben visibili, sia nei fregi e nella stele romana inseriti negli stipiti
della porta, sia all'interno dove si può ammirare un mosaico pavimentale
romano a cerchi neri custodito nella prima cappella di destra.
La stele marmorea inserita nello stipite di
sinistra è dedicata alla memoria di un bambino morto, Lucio Duanzio Valentino
ed è databile intorno al III-IV secolo d.C..
L'orientamento originario della chiesa romanica,
la cui apertura era volta a Ovest, fu mutato in quello attuale con
l'intervento per l'edificazione della chiesa di San Vincenzo. I citati scavi
archeologici portarono alla luce anche l'abside della chiesa originaria che è
visibile oltre la porticina a destra dell'ingresso attuale.
All'interno è custodita un'importante serie di
affreschi che fanno di San Vincenzo uno dei più importanti monumenti
dell'Alto Lario. I lavori di restauro, terminati nel 1980, hanno messo in
luce diversi interventi decorativi succedutisi nel tempo fra cui, il più
importante quello che interessò il presbiterio tra il 1546 e il 1547, su
commissione dalla Società dei Naviganti di Gera. L'altare maggiore è adornato
da un pregevole polittico raffigurante una Crocifissione e la Madonna
in trono col Bambino. Le immagini dei Dottori della Chiesa intenti alla
studio dei testi sacri e la sequenza di Santi che si sviluppa sui pilastri,
sono un sicuro richiamo alla rigorosa osservanza della tradizione cattolica e
sono da leggersi in chiave anti luterana.
Lasciata San Vincenzo e ritornati sulla
carrozzabile pieghiamo a sinistra tornando sulla sponda opposta del torrente
della Val di Gera per imboccare, ancora verso sinistra, la strada per
Bugiallo e Montemezzo. Fatti pochi metri abbandoniamo l'asfalto per deviare a
destra entrando in una stradina acciottolata. Il viottolo ci porta in breve
fra le case di Gera Lario dove. qua e là, avremo modo di scoprire i segni
dell'antico passato: stiamo, infatti, percorrendo un tratto dell'originaria
via romana. In leggera discesa si arriva, infine, a lambire le severe mura di
pietra della chiesa di Nostra Signora di Fatima il cui ingresso s'apre su un
ampio piazzale. Verso monte il piazzale è delimitato dalle facciate del
centro storico di Sorico, quasi tutte abbellite da affreschi. Fra le dimore
si insinuano strette viuzze che invitano ad una breve digressione dal
percorso per andare a visitare il cuore del paese. Il tessuto urbano è
costituito da molti edifici risalenti al 1500, ai quali si aggiungono altre
case sei-settecentesche. Particolarmente suggestivo il disegno viario che,
pur nella sua regolarità, appare movimentato da passaggi coperti, loggiati e
scalette.
Traversata nuovamente la statale, proprio di
fronte alla chiesa di Nostra Signora di Fatima, s'imbocca un camminamento
lastricato (che funge anche da pista ciclabile) per tornare sulle rive del
lago. Si piega, ora, a sinistra e si continua lungo il camminamento con belle
vedute panoramiche sui monti che si specchiano nelle tranquille acque
lariane. Stormi di anatre e gruppi di cigni incrociano sulle tranquille
acque, intenti a socializzare e a cacciare piccoli pesci.
Al termine della ciclabile si prosegue nei pressi
della riva sfruttando una passerella di legno e poi un sentiero che lambisce
il recinto di due campeggi per terminare in una grande area verde attrezzata.
Verso Nord-est svetta la massiccia mole rocciosa del Sasso Manduino che
s'erge a separare la Val Codera dalla Val dei Ratti e sembra quasi proteggere
la bianca chiesetta di San Miro incastonata fra le selve poco sopra Sorico.
Dopo questo lungo tratto sulle rive del lago,
piegando a sinistra e traversando l'area verde, ci si allontana dalle acque
puntando all'evidente, massiccia torre campanaria della parrocchiale di Santo
Stefano in Sorico. La torre è quanto rimane dell'originario impianto romanico
della chiesa, mentre il resto dell'edificio ha subito diversi rimaneggiamenti
nel corso dei secoli e, in particolare, nel quattrocento e nel settecento.
Del primo intervento rimangono il bel portale marmoreo, alcuni tratti delle
mura come l'arco a sesto acuto all'altezza della seconda cappella di destra,
la vasca battesimale e l'affresco raffigurante una Crocifissione che
orna la parete dell'abside, me è nascosto da un trittico cinquecentesco con
una scena della Madonna che allatta il Bambino fra S. Stefano e S.
Vincenzo.
Dal sagrato della chiesa seguiamo ora la Statale
puntando verso la chiesa di San Miro il cui bianco edificio domina la visuale
in direzione Est. Si percorre una strada di servizio separata dalla
carrozzabile principale mediante un guard rail e, ben presto, si giunge al
suo termine presso alcune casette ben ristrutturate. Ci si infila fra le case
seguendo un viottolo acciottolato e, tramite un ponticello, si traversa il
torrentel che scende da una vallecola soprastante. Al di là del ponte, ai
piedi di un'antica torre di guardia restaurata e oggi facente parte di
un'abitazione, inizia la salita verso San Miro. I cartelli indicatori non
lasciano dubbi: una ripida mulattiera, a gradini, s'innalza fra la torre e il
rio che abbiamo appena traversato. La sequenza dei gradini ci porta man mano
in alto. Dopo aver lambito una cappella dedicata a San Miro, ed eretta nel
1598 a protezione di una fonte, eccoci nel sagrato della chiesa da dove si
apre uno splendido panorama sul Lario.
Fino al 1452 la chiesa, di origini romaniche, era
dedicata al culto di San Michele; ma, in quell'anno, nella cappella di S.
Antonio, furono ritrovate le spoglie di Miro da Canzo qui deceduto verso il
1381 e alla cui figura erano legate diverse leggende. Si diceva, fra l'altro,
che Miro fosse giunto fino a Sorico stendendo il suo mantello sulle acque del
lago e camminandoci sopra. Il ritrovamento delle reliquie innescò un
movimento di fedeli che portò al rinnovamento dell'edifico che fu dedicato a
San Miro. Il culto del santo ebbe vasta diffusione in Brianza e, in
particolare, a Milano che, nel 1491, organizzò addirittura un pellegrinaggio
al santuario.
Risalgono al rinnovamento quattrocentesco due
affreschi raffiguranti la Madonna col Bambino e quelli della Madonna
del latte e della Madonna in trono, una Crocifissione e un San
Sebastiano visibile sul primo pilastro di sinistra.
Nel 1526, il pittore Sigismondo De Magistris
inaugurava un nuovo ciclo decorativo che interessò l'area compresa fra i due
pilastri che separano la navata centrale da quella di destra. Qui fu
probabilmente sepolto il corpo di San Miro, sotto un altare lui intitolato.
Gli affreschi raffigurano i Santi ed i Profeti, Dio Padre, i SS
Miro, Vincenzo, Michele e Stefano e gli Angeli
musicanti. Oltre ai pregevoli cicli di affreschi, la chiesa conserva una
tela del 1615, attribuita al Fiamminghino.
L'attuale impianto della chiesa è costituito da
tre navate solo in parte coperte da volte in muratura.
Il ritorno è quanto mai semplice e immediato. In
pochi minuti si ridiscende sul deposito alluvionale dove sorgono Sorico e
Gera Lario. A questo punto non resta che scegliere uno dei tanti ristorantini
tipici dove riposare gustando le specialità locali e, in particolare, i
piatti a base di pesce del lago.
|
|
LA VALLE DEL LIRO
Lungo
la strada che risale la Valle del Liro, la prima frazione che
s'incontra è S. Carlo. Qui una stradina a destra conduce alla chiesa
omonima (sec. XVII), oltre la quale si trova la frazione di Segna, raccolta
attorno alla chiesetta di S. Lorenzo (sec. XVI). Superati i piccoli abitati
rurali di Travisa e di Rancio, si arriva a Traversa, dove sorge la chiesa
di S. Martino (sec. XVII). Poco distante da essa, situata su un poggio
isolato, raggiungibile a piedi (h. 0.10), si trova la suggestiva <B<
in Pietro S.>, che dell'originaria struttura romanica conserva l'abside,
mentre l'impianto generale risale al sec. XV. L'interno presenta bellissimi
affreschi cinquecenteschi ed un antico altare ligneo. La leggenda
vuole che qui si nascondano i tesori dei gravedonesi, che in passato
erano soliti rifugiarvisi in occasione di guerre e pestilenze.
Un'altra leggenda vuole anche che, sempre nelle sue vicinanze, cadendo in
una delle forre del Liro, morisse Gian Mauro della Rovere detto il
Fiammenghino, il famoso pittore che, agli inizi del Seicento, accusato
di omicidio, scappò da Milano e si rifugiò in Alto Lario, ricevendo
numerose commesse per affrescare le chiese della zona (in realtà morì e
venne sepolto a Milano, nel 1640).
Subito dopo Traversa si trova il bivio per Dosso del Liro e Peglio.
Il primo lo si raggiunge in breve tempo, dopo aver superato le antiche case
in pietra di Scivano. Situato a mezza costa del Monte Piaghedo (m. 1454),
Dosso del Liro presenta un aspetto rurale, con case adossate le une
alle altre e strette e ripide stradine. Sulla piazzetta del paese sorge la
chiesa barocca della SS. Annunziata (sec. XVII). Da Dosso del Liro si può
proseguire in auto fino al Pian delle Castagne (km. 2) e da qui compiere
escursioni al Rifugio Vincino (m. 1104, h. 1.15) e al Monte
Cardinello (m. 2521, h. 5).
 Di eguale
aspetto contadino, con antiche case rurali, è anche Peglio. Poco
prima di entrare in paese, su una collina a dominio della piana di
Gravedona e del Lago, sorge la bellissima chiesa di S. Eusebio.
Ricostruita agli inizi del sec. XVII, la chiesa è preceduta da un portico
cinquecentesco, riccamente affrescato. L'interno della chiesa presenta opere
del Fiammenghino (si noti il suo autoritratto nella cappella del
battistero, dove l'artista si è raffigurato in abito bianco, con cappello e
spada, accanto alla sua compagna e ai suoi figli). Di eguale
aspetto contadino, con antiche case rurali, è anche Peglio. Poco
prima di entrare in paese, su una collina a dominio della piana di
Gravedona e del Lago, sorge la bellissima chiesa di S. Eusebio.
Ricostruita agli inizi del sec. XVII, la chiesa è preceduta da un portico
cinquecentesco, riccamente affrescato. L'interno della chiesa presenta opere
del Fiammenghino (si noti il suo autoritratto nella cappella del
battistero, dove l'artista si è raffigurato in abito bianco, con cappello e
spada, accanto alla sua compagna e ai suoi figli).
Poco oltre Peglio, nei pressi dell'oratorio della Madonna (sec. XVII), una
strada sterrata sulla destra conduce a Naro (km. 1,8), un tempo
importante comune della valle, abbandonato in seguito alla continua
emigrazione dei suoi abitanti e alle pestilenze. Qui sorge la piccola
chiesa di S. Croce, dagli interni decorati con affreschi del sec. XVI.
Situato nel Pian di Gorghi, al margine della bellissima Val Darengo,
anche Livo, al pari degli altri paesi, presenta una struttura
tipicamente rurale, con stretti viali acciottolati e antiche case in
pietra, alcune delle quali affrescate con soggetti religiosi (sec. XVI).
Qui, come a Vercana, le donne erano solite vestire il costume tradizionale
della moncecca, a ricordo dell'emigrazione a Palermo dei sec. XVI e
XVIII. In centro paese sorge la chiesa parrocchiale di S. Giacomo (sec.
XVII) e, poco fuori l'abitato, nei pressi del cimitero, la vecchia
parrocchiale omonima, risalente al sec. XV, con uno stupendo ciclo di
affreschi cinquecenteschi.
Da qui si può proseguire a piedi fino a Dangri (h 1) e oltrepassato
il santuario della Madonna di Livo (sec. XVII), salire alla Capanna Como
(m. 1790, h.4), il più antico rifugio costruito dal Cai di Como.
|
LA STRADA REGINA
L'attuale tracciato
della strada Regina rispecchia solo in parte quello che anticamente
collegava Como ai passi alpini dello Spluga, del Septimer e del
Maloja-Julier. Già in epoca preromana, una via terrestre doveva esistere
sulla sponda occidentale del lago. Probabilmente, doveva trattarsi di un tracciato
mutevole, legato alle difficili condizioni del terreno (frane, alluvioni,
ecc.).
 Di esso non è rimasta
traccia, nè sarebbe possibile oggi identificarlo con precisione. Altrettanto
dubbio è il percorso seguito dalla stessa strada in epoca romana. A
differenza delle grandi strade dei valichi alpini, infatti, la via Regina non
fu attrezzata dai Romani con ponti in pietra o altri manufatti. Doveva più
che altro trattarsi di un tratturo angusto, a fondo naturale, con
pendenze anche del 25-30% e ponti in legno a scavalcare i numerosi torrenti. Di esso non è rimasta
traccia, nè sarebbe possibile oggi identificarlo con precisione. Altrettanto
dubbio è il percorso seguito dalla stessa strada in epoca romana. A
differenza delle grandi strade dei valichi alpini, infatti, la via Regina non
fu attrezzata dai Romani con ponti in pietra o altri manufatti. Doveva più
che altro trattarsi di un tratturo angusto, a fondo naturale, con
pendenze anche del 25-30% e ponti in legno a scavalcare i numerosi torrenti.
In queste condizioni si comprende come il modo più agevole e veloce per
raggiungere l'Alto Lago (allora il punto di arrivo era Samolaco), dovesse
essere la via d'acqua. I comballi o altre imbarcazioni dell'epoca
rendevano infatti più sicuro il viaggio dalla pianura verso i passi alpini,
consentendo inoltre il trasporto di un carico maggiore di merci. Bisogna
quindi rivedere l'idea che la strada Regina fosse una via importante
("Regia", appunto) già in epoca romana. Durante questo periodo,
essa fu tutt'al più una via di comunicazione sussidiaria rispetto a quella
lacuale, servendo essenzialmente come strada di collegamento locale tra i
vari insediamenti del lago.
La sua funzione di grande strada di comunicazione iniziò solo all'indomani
della caduta dell'impero Romano e del relativo consolidamento del Regno dei
Longobardi. In epoca altomedioevale la strada Regina andò arricchendosi di
ponti, di torri daziarie e di chiese. Per questo motivo, il nome
"Regina" è stato in seguito associato a quello della regina
longobarda Teodolinda, cui molto si dovette per l'avvaloramento del
territorio lariano.
Le prime notizie scritte riguardo all'esistenza della strada Regina risalgono
al 1335, quando negli "Statuti Comensi" si indicarono gli
obblighi di manutenzione che competevano, per determinati suoi tratti, ai
vari paesi del lago (compresi anche quelli della sponda opposta, in quanto
comunque beneficiarii).
La Regina viene anche ricordata da Paolo Giovio (1537), in riferimento
soprattutto al difficile passaggio del Sasso Rancio (Menaggio), sopra
l'odierno santuario della Madonna della Pace. La tradizione vuole che proprio
in questo punto, alla fine del Settecento, uno squadrone di cosacchi
fosse precipitato nel lago, per non esser voluto smontare da cavallo. Oggi,
testimonianze dell'antica via Regina si ritrovano un po' ovunque nei paesi
del lago. In alcuni punti, inoltre, come nel tratto fra Musso e Barbignano,
sulla mulattiera che scende dalla chiesetta di S. Eufemia, si possono ancora
vedere i solchi lasciati anticamente dai carri.
Da alcuni anni, infine, esiste anche un'associazione "Antica strada
regina" (tel. 031-260022), che si occupa dello studio e della
valorizzazione di questo tracciato. Visite guidate sono organizzate dalla
cooperativa "Imago" (tel.0344-82572).
|
|
IL PIANO DI SPAGNA
 Il Piano di Spagna è una pianura alluvionale, formatasi
per l'apporto di materiale detritico da parte del fiume Adda. Migliaia di anni
fa il Lago di Como era quindi tutt'uno con il Lago di Mezzola. Il toponimo di
<B< (?Summus>lo sta ancora oggi a testimoniare. Il Piano di Spagna è una pianura alluvionale, formatasi
per l'apporto di materiale detritico da parte del fiume Adda. Migliaia di anni
fa il Lago di Como era quindi tutt'uno con il Lago di Mezzola. Il toponimo di
<B< (?Summus>lo sta ancora oggi a testimoniare.
Abitato fin in epoca romana, come confermato dai ritrovamenti archeologici
nella zona di Sant'Agata (dove un tempo sorgeva la romana Aneunia), il Piano
di Spagna deve il suo nome al dominio spagnolo (sec. XVI-XVIII). Per
la sua posizione strategica, questa pianura ospitò, a partire dal
Medioevo, diverse fortificazioni, che vennero poi ampliate dagli spagnoli. Da
qui infatti passava il confine tra i Grigioni, che controllavano la
Valtellina e il Ducato di Milano, allora sono la corona di Spagna.
Per questo motivo, il conte di Fuentes,
governatore di Milano, decise di costruirvi un forte. Situato sulla collina settentrionale
di Montecchio, il Forte fu in collegamento con altre postazioni
difensive, come la Torre di Sorico, il Forte d'Adda (oggi riattato a stalla e
quindi detto lo "Stallone"), la Torre di Curcio e quella di
Fontanedo.
Il Forte di Fuentes resistette ad attacchi di diversi eserciti e venne
smantellato solo nel 1796, da Napoleone Bonaparte. Durante la prima
guerra mondiale, il Forte funzionò come punto di osservazione per il vicino Forte
Lusardi o Forte Montecchio, costruito nel 1914 e diventato in seguito
presidio del Ridotto alpino repubblicano (per la visita, tel. 338-5926220).
Oggi del Forte di Fuentes rimangono solo imponenti resti di mura, immerse in
una fitta vegetazione (vi si accede dal Trivio di Fuentes).
Il Piano di Spagna è noto anche per essere una tra le più importanti
riserve naturali della Regione. Qui, tra i canneti e le tife, nidificano
numerose specie di uccelli acquatici (cigno reale, folaga, gallinella
d'acqua, ecc.), di anfibi (tritone crestato, rana verde, rospo comune,
ecc.) e di rettili (testuggine palustre, biscia dal collare, ramarro,
ecc.). Per avere una visione d'insieme dell'oasi naturale si può salire ad Albonico,
frazione di Gera Lario, che ospita fra l'altro una stazione d'osservazione
ornitologica.
Da ricordare, infine, sulla sponda occidentale del Lago di Mezzola, lungo il
tracciato dell'antica via Regina, il gioiello architettonico di S.
Fedelino (accessibile a piedi - h.1,30 - da Samolaco e, via barca, da
Novate Mezzola), oratorio protoromanico del sec. X, con affreschi coevi,
sorto sul presunto luogo del martirio di S. Fedele (per visite guidate,
cooperativa "Imago", tel. 0344-82572).
|
|
DA
CONSIGLIO DI RUMO A SORICO
 Lasciato alle spalle Dongo, prima di entrare a Gravedona, la strada
Regina attraversa il paese di Consiglio di Rumo, la cui antica
oligine pre-romana è ricordata nel suo toponimo. Il "concilium",
infatti, era un'istituzione politica politica celtica che indicava l'insieme
dei territori federati attorno ad un unico centro (i Rumo furono invece una
famiglia nobile dei sec. XIII-XV). Situato sulla piana deltizia del Liro,
Consiglio di Rumo è oggi un paese dall'aspetto relativamente moderno. Lasciato alle spalle Dongo, prima di entrare a Gravedona, la strada
Regina attraversa il paese di Consiglio di Rumo, la cui antica
oligine pre-romana è ricordata nel suo toponimo. Il "concilium",
infatti, era un'istituzione politica politica celtica che indicava l'insieme
dei territori federati attorno ad un unico centro (i Rumo furono invece una
famiglia nobile dei sec. XIII-XV). Situato sulla piana deltizia del Liro,
Consiglio di Rumo è oggi un paese dall'aspetto relativamente moderno.
Poco discosta dalla strada Regina, sorge la chiesa parrochiale di S.
Gregorio, di stile quattrocentesco (ma di costruzione più recente), con
un'abside presumibilmente del sec. XIV ed un campanile del sec.XV-XVI.
All'interno sono stati portati alla luce lacerti di affreschi quattrocenteschi,
che si affiancano a quelli ad opera di Carlo Pozzi di Valsolda (1659). Fra
le numerose frazioni di consiglio di Rumo, merita un cenno Brenzio,
dove, in posizione panoramica, sorge la chiesetta di S. Giovanni Battista
(sec. XV), il cui interno vanta importanti affreschi della meta del
Seicento, di Isidoro Bianchi da Campione (nel presbiterio) e del
Fiammenghino (nelle due cappelle laterali).
 Distesa ai piedi del Sasso Pelo (m. 910), in una tranquilla
insenatura, Gravedona è uno tra i paesi del lago più ricchi di
vestigia architettoniche. Di origine gallica (Gravedona deriva dal
celtico "grava" = arca ghiaiosa), divenne centro di un vasto
"pagus" (distretto) in epoca romana. Durante il Medioevo fu
coinvolta nelle lotte comunali fra Como e Milano e successivamente,
esercitò, assieme a Dongo e Sorico (le cosiddette "Tre Pievi"),
un controllo duraturo sulla zona dell'Alto Lago. Delle 'Tre Pievi'
s'impossessarono, nel sec. XVI, prima il Medeghino e poi il card. Tolomeo
Gallio, che a Gravedona costruì il suo famoso palazzo (oggi sede della
Cotmunità montana), su disegno di Pellegrino Tibaldi. Dell'antico castello
medioevale e del borgo fortificato oggi non rimangono che scarse tracce
murarie, nella Frazione Castello, alle spalle del Municipio. Distesa ai piedi del Sasso Pelo (m. 910), in una tranquilla
insenatura, Gravedona è uno tra i paesi del lago più ricchi di
vestigia architettoniche. Di origine gallica (Gravedona deriva dal
celtico "grava" = arca ghiaiosa), divenne centro di un vasto
"pagus" (distretto) in epoca romana. Durante il Medioevo fu
coinvolta nelle lotte comunali fra Como e Milano e successivamente,
esercitò, assieme a Dongo e Sorico (le cosiddette "Tre Pievi"),
un controllo duraturo sulla zona dell'Alto Lago. Delle 'Tre Pievi'
s'impossessarono, nel sec. XVI, prima il Medeghino e poi il card. Tolomeo
Gallio, che a Gravedona costruì il suo famoso palazzo (oggi sede della
Cotmunità montana), su disegno di Pellegrino Tibaldi. Dell'antico castello
medioevale e del borgo fortificato oggi non rimangono che scarse tracce
murarie, nella Frazione Castello, alle spalle del Municipio.
 Qui sorgono anche le abitazioni più antiche di Gravedona, alcune
delle quali risalenti ai sec. XIII-XV. L'edificio però più insigne del
paese e di tutto l'Alto Lago è la chiesa romanica di S. Maria del Tiglio
(sec. XII). Co-struita sul luogo ove sorgeva un precedente battistero
paleocristiano (sec. V-VI), di cui conserva, all'esterno, degli altorilievi
simbolici, murati sopra il suo portale e all'interno il fonte battesimale e
tracce dell'antico pavimento a mosaico, la chiesa presenta un
caratteristico campanile addossato alla facciata. Il suo interno,
semplice ed armonioso, è impreziosito dalla presenza di affreschi dei sec
XIV-XV. Qui sorgono anche le abitazioni più antiche di Gravedona, alcune
delle quali risalenti ai sec. XIII-XV. L'edificio però più insigne del
paese e di tutto l'Alto Lago è la chiesa romanica di S. Maria del Tiglio
(sec. XII). Co-struita sul luogo ove sorgeva un precedente battistero
paleocristiano (sec. V-VI), di cui conserva, all'esterno, degli altorilievi
simbolici, murati sopra il suo portale e all'interno il fonte battesimale e
tracce dell'antico pavimento a mosaico, la chiesa presenta un
caratteristico campanile addossato alla facciata. Il suo interno,
semplice ed armonioso, è impreziosito dalla presenza di affreschi dei sec
XIV-XV.
Accanto a S. Maria del Tiglio si trova la chiesa parrocchiale di S.
Vincenzo, edificio romanico (ristrutturato nel sec. XVII), anch'esso
costruito su una preesistente basilica paleocristiana. Nella cripta
romanica, che potrebbe forse identificarsi con la zolla presbiteriale della
basilica paleocristiana, è visibile un'antichissima pavimentazione, che
rimanderebbe forse all'esistenza di un tempio pagano.
 Tra gli altri edifici religiosi sono da ricordare, lungo la strada
Regina, nei pressi del ponte sul Liro, l'oratorio di S. Abbondio (sec.
XVII), con un caratteristico campaniletto a vela. A monte della stessa
strada, immersa in un bel parco, è la chiesa romanica dei SS. Gusmeo e
Matteo, che la tradizione vuole essere stati qui martirizzati. Rifatta
nel sec. XVI, la chiesa conserva al suo interno pregevoli affreschi del
Fiammenghino (1608). Tra gli altri edifici religiosi sono da ricordare, lungo la strada
Regina, nei pressi del ponte sul Liro, l'oratorio di S. Abbondio (sec.
XVII), con un caratteristico campaniletto a vela. A monte della stessa
strada, immersa in un bel parco, è la chiesa romanica dei SS. Gusmeo e
Matteo, che la tradizione vuole essere stati qui martirizzati. Rifatta
nel sec. XVI, la chiesa conserva al suo interno pregevoli affreschi del
Fiammenghino (1608).
Poco sopra, in posizione panoramica, sorge l'importante chiesa di S.
Maria delle Grazie (sec. XV), con annesso convento agostiniano (in
restauro). Di semplice facciata, ornata da un elegante portale in marmo, la
chiesa presenta un suggestivo interno, riccamente affrescato (1496-1520). Sul
lungolago, nei pressi del centro storico, sorge la piccola chiesa della
Madonna della Soledad (sec. XVII), mentre sulle colline sovrastanti
Gravedona, a Negrana, si trova la chiesa dei SS. Nabore e Felice (sec.
XVI).
Affacciata sul lago, alla foce del torrente Livo, Dornaso è oggi un
importante centro turistico, con numerosi campeggi, frequentati dagli
appassionati degli sport a vela, che qui godono, nei mesi estivi, di
venti costanti, come la breva e il tivano. In antagonismo secolare
con Gravedona, Domaso vanta anch'essa un importante passato comunale. Lo
dimostra l'ampio centro storico, arricchito qua e là, fra gli stretti
vicoli, da antiche case, portali in pietra e affreschi votivi.
La chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo è un rifacimento secentesco
del primitivo edificio romanico. Al suo interno, oltre ad alcuni dipinti ed
affreschi dei sec. XV e XVII, si trova anche la tomba di Luigi Panizza
(1639), governatore del Forte di Fuentes. Poco distante, sorge l'ex
convento degli Umiliati, con l'annessa chiesa quattrocentesca di S. Maria.
Da ricordare, inoltre, lungo la via Regina, la settecentesca Villa
Camilla, già dei Sebregondi (oggi sede municipale).
Subito fuori Domaso, s'incontra a sinistra la deviazione per Vercana,
che si raggiunge dopo breve salita, a metà della quale sorge il bel
santuario della Madonna della Neve (1634), costruzione votiva in
ricordo della peste che seguì la calata dei Lanzichenecchi. Costituita
dalle frazioni di Arbosto (sede comunale) e di Caino, anche Vercana, come
molti paesi delle valli dell'Alto Lago, subì fra il sec. XVI e il XVIII,
una massiccia emigrazione verso la Sicilia (a Palermo in
particolare).
Riuniti in confraternite (denominate "scholae"), questi emigrati
non dimenticavano però il loro paese natio, cui spesso inviavano a soldi
per abbellire le locali chiese magari anche con affreschi o statue
raffiguranti S. Rosalia (protettrice di Palermo). E' questo appunto il caso
della parrocchiale di S. Salvatore (sec. XVII) ad Arbosto -
riccamente decorata in stile barocco - e di quella di S. Sebastiano (sec.
XVII), a Caino. Da sottolineare, inoltre, come le donne di Vercana, ancora
fino agli inizi del secolo, fossero solite vestire la "muncecca",
tipico costume femminile dell'Alto lago, ispirato al saio delle monache
palermitane.
Ritornati sulla strada statale, si prosegue in direzione di Gera Lario.
L'origine romana di questo insediamento è attestata dai resti di un
pavimento del sec.II, visibili nella prima cappella a destra della chiesa
parrocchiale di S. Vincenzo, nel cui portale è anche murata una stele
funeraria del sec. II. Situata lungo la strada Regina, S. Vincenzo è una
tra le chiese più importanti dell'Alto lago. Di origine romanica, oggi si
presenta in forme quattrocentesche. Stupendi gli affreschi che la decorano
internamente, risalenti alla metà del Cinquecento.
 Poco oltre la chiesa, sorge il centro storico di Gera Lario, che si
sviluppa alle spalle dell'imponente chiesa di Nostra Signora di Fatima
(sec. XVIII). Arricchito da alcune abitazioni gentilizie, sulle cui
facciate vi sono affreschi devozionali rislaenti ai sec. XVI-XVIII,
il centro è attraversato dall'antica strada Regina. Poco oltre la chiesa, sorge il centro storico di Gera Lario, che si
sviluppa alle spalle dell'imponente chiesa di Nostra Signora di Fatima
(sec. XVIII). Arricchito da alcune abitazioni gentilizie, sulle cui
facciate vi sono affreschi devozionali rislaenti ai sec. XVI-XVIII,
il centro è attraversato dall'antica strada Regina.
Prima di raggiungere Sorico, ultima tappa dell'itinerario, si può compiere
una deviazione a monte di Gera Lario, per visitare i comuni di Trezzone
e di Montemezzo. Il primo, costituito dalle frazioni di Folciano e
di Aurogna (sede municipale), presenta, soprattutto in quest'ultima
frazione, pregevolissimi esempi di architettura rurale, immersi in
un'atmosfera altamente suggestiva. Fra le due frazioni, situata in
posizione panoramica, sorge la chiesa di S. Maria delle Grazie, di
forme quattrocentesche, con interni barocchi. A Trezzone la prima domenica
di settembre si celebra S. Rosalia, a ricordo del flusso migratorio dei
suoi abitanti a Palermo (sec. XVI-XVllI).
In altrettanto bella posizione panoramica, si trova il comune di Montemezzo,
formato dai due nuclei principali di Burano (sede municipale) e di
Montalto. A Burano, caratteristico borgo rurale, sorge la chiesa di S.
Martino (sec. XV-XVI), riccamente affrescata all'interno da Aurelio Lumi.
Agli inizi del Seicento, la chiesa si arricchì di due cappelle laterali,
donate rispettivamente dagli emigrati a Palermo e ad Ancona. Imboccando la
strada per le frazioni di Peledo e San Bartolomeo, è possibile effettuare
una panoramica escursione al Monte Berlinghera (m. 1930, h. 2.15),
rifugio, durante la Resistenza, dei partigiani della 52a Brigata Garibaldi
(la stessa che catturò Mussolini).
Situata alla foce del fiume Mera, Sorico fu, anticamente, una delle
"Tre Pievi" che ebbero il controllo dell'Alto lago. Questo titolo
lo ereditò nel sec. XV dalla pieve di Olonio, la romana Aneunia, che
sorgeva nel Piano di Spagna, nei pressi dell'odierna Sant'Agata e che fu
abbandonata dai suoi abitanti, a causa delle continue alluvioni dell'Adda.
 In occasione di questo trasferimento, venne ampliata la chiesa di
S. Stefano, a Sorico. Oggi la stessa si presenta nel suo ultimo rifacimento
settecentesco, conservando delle precedenti fasi costruttive solo il
possente campanile romanico (già torrione difensivo) e parti dell'abside e
del portale quattrocenteschi. In occasione di questo trasferimento, venne ampliata la chiesa di
S. Stefano, a Sorico. Oggi la stessa si presenta nel suo ultimo rifacimento
settecentesco, conservando delle precedenti fasi costruttive solo il
possente campanile romanico (già torrione difensivo) e parti dell'abside e
del portale quattrocenteschi.
A monte dell'abitato di Sorico, raggiungibile a piedi attraverso una breve
mulattiera su cui è ancora oggi visibile una delle molte torri medioevali
che un tempo caratterizzavano il tracciato dell'antica strada Regina, si
trova il santuario di S. Miro. La piccola chiesa, sotto il cui
altare maggiore è conservato il corpo dell'omonimo eremita di Canzo, qui
morto attorno al 1381, presenta bellissimi affreschi del sec. XV-XVI. In
altra frazione a monte di Sorico, Bugiallo, raggiungibile in auto,
sorge la secentesca chiesa di S. Giovanni Battista.
|
|

|
Ombre, al rintocco dell'Ave Maria, nella valle senza strada
|

|
|
 La Val Codera, una delle
più suggestive ed amate in provincia di Sondrio, in quanto ancora
preservata dall’accesso degli autoveicoli per la mancanza di una strada
carrozzabile, è anche una delle più ricche di leggende legate ad ombre,
presenze inquietanti e stregonerie. Molti anziani raccontano ancora di
aver udito, o aver vissuto di persona, incontri con uomini ed animali
misteriosi, rivelatisi poi manifestazioni di anime malvagie o di streghe. La Val Codera, una delle
più suggestive ed amate in provincia di Sondrio, in quanto ancora
preservata dall’accesso degli autoveicoli per la mancanza di una strada
carrozzabile, è anche una delle più ricche di leggende legate ad ombre,
presenze inquietanti e stregonerie. Molti anziani raccontano ancora di
aver udito, o aver vissuto di persona, incontri con uomini ed animali
misteriosi, rivelatisi poi manifestazioni di anime malvagie o di streghe.
La figura più
celebre è quella del Valfubia, su cui si narrano diverse storie. Costui
era un uomo malvagio, che rubava anche a persone povere, per cui fu
condannato a vagare, come un’anima in pena, di notte, assumendo sembianze
sempre diverse, ora di uccello rapace, ora di maiale, ora di ombra
inafferabile. Dicono che le sue urla lamentevoli fossero davvero
impressionanti. Come spesso accade in questi casi, per risarcirsi della
sua condizione infelice prendeva di mira quanti si trovassero a
transitare da soli su sentieri della valle, o anche uscissero di casa la
sera, nella zona compresa fra Codera e Bresciadega. Faceva, quindi,
rotolare contro di loro sassi dalle gande, oppure, più spesso, si
materializzava improvvisamente, fra le ombre della sera, terrorizzando i
malcapitati con un forte soffio. L’unico modo per tenerlo alla larga era
munirsi di un rosario: quel segno di devozione e preghiera, infatti,
riusciva insopportabile alla sua anima malvagia.
Più inquietante ancora
del Valfubia è la figura di un uomo misterioso che terrorizzava, sempre
nottetempo, i viandanti sui sentieri nei dintorni di Cola e di San
Giorgio.  La sua dimora era in una grotta nascosta, da qualche parte nei
pressi del sentiero che unisce i due paesi scendendo nel cuore oscuro
dell’impressionante vallone di Revelaso. Chi lo aveva visto lo descriveva
come un individuo vestito in modo bizzarro, ben diverso da quello
semplice ed essenziale dei contadini: portava una giacca nera su
pantaloni e stivali marroni. Talvolta di lui si udivano solo rumori, il
fruscio dei rami degli alberi che scuoteva per far paura alla gente,
oppure si intuiva la presenza, dietro qualche anfratto o qualche fronda,
quando i lupi, suoi amici, ululavano nelle notti di luna piena, perché,
si dice, se ne stava sempre nascosto a spiare le persone che passavano.
Ma non si limitava a questo: altre volte scatenava la sua malvagità
giungendo ad uccidere i viandanti, tanto che si era creato un terrore
tale che la gente, al calar delle prime ombre della sera, non solo non
usciva più di casa, ma vi si chiudeva proprio dentro a chiave,
sussultando ad ogni rumore nella soffitta o alla porta di casa. Non si
poteva più andare avanti così, ed allora venne decisa una vera e propria
battuta di caccia, cui parteciparono tutti gli uomini dei due paesi, ed
anche qualche donna coraggiosa. Guidati dal lume della luna e delle
lanterne e muniti di robusti bastoni di castagno, costoro setacciarono i
boschi della zona. Alla fine la loro tenacia fu premiata, perché apparve,
fra gli alberi, l’ombra dell’uomo malvagio, che fu riempito di energiche
bastonate e scaraventato nel cuore del vallone, dal quale non riemerse
più. Rimasero, di lui, solo i flebili lamenti che, durante i temporali,
salivano dalla Caurga. Ma nessuno ebbe più nulla di cui temere, da
allora. La sua dimora era in una grotta nascosta, da qualche parte nei
pressi del sentiero che unisce i due paesi scendendo nel cuore oscuro
dell’impressionante vallone di Revelaso. Chi lo aveva visto lo descriveva
come un individuo vestito in modo bizzarro, ben diverso da quello
semplice ed essenziale dei contadini: portava una giacca nera su
pantaloni e stivali marroni. Talvolta di lui si udivano solo rumori, il
fruscio dei rami degli alberi che scuoteva per far paura alla gente,
oppure si intuiva la presenza, dietro qualche anfratto o qualche fronda,
quando i lupi, suoi amici, ululavano nelle notti di luna piena, perché,
si dice, se ne stava sempre nascosto a spiare le persone che passavano.
Ma non si limitava a questo: altre volte scatenava la sua malvagità
giungendo ad uccidere i viandanti, tanto che si era creato un terrore
tale che la gente, al calar delle prime ombre della sera, non solo non
usciva più di casa, ma vi si chiudeva proprio dentro a chiave,
sussultando ad ogni rumore nella soffitta o alla porta di casa. Non si
poteva più andare avanti così, ed allora venne decisa una vera e propria
battuta di caccia, cui parteciparono tutti gli uomini dei due paesi, ed
anche qualche donna coraggiosa. Guidati dal lume della luna e delle
lanterne e muniti di robusti bastoni di castagno, costoro setacciarono i
boschi della zona. Alla fine la loro tenacia fu premiata, perché apparve,
fra gli alberi, l’ombra dell’uomo malvagio, che fu riempito di energiche
bastonate e scaraventato nel cuore del vallone, dal quale non riemerse
più. Rimasero, di lui, solo i flebili lamenti che, durante i temporali,
salivano dalla Caurga. Ma nessuno ebbe più nulla di cui temere, da
allora.
Torniamo, ora, verso
Codera, e fermiamoci al maggengo di Cii, posto su un bellissimo terrazzo
panoramico che guarda al lago di Novate. Qui ci accoglie una delle più
classiche storie di stregonerie. Protagonista un giovane di Codera,
fidanzato ad una ragazza di Cii.  Un giorno, mentre si recava a trovarla, si imbattè in una volte
misteriosa e, seguendola, si accorse che entrava proprio nella casa della
fidanzata. Sbirciando, vide che questa e la madre, vestite della festa,
ungevano tempie, polsi e caviglie, pronunciando poi la formula “Tre ur
andà, tre ur a sta e tre ur a venì” e volando via attraverso la cappa del
camino. Preso dalla curiosità, pronunciò anche lui la formula, ma,
essendo furbo, apportò qualche modifica e disse “Un ur andà, un ur a sta
e un ur a venì”. Si ritrovò, così, in un grande salone, nel quale erano
riunite molte persone, anche morte, mentre un misterioso individuo, dalle
gambe caprine, scriveva su un librone il nome dei presenti. Lui tracciò
sul librone una croce, perché non sapeva scrivere, ed allora accadde
qualcosa di ancora più incredibile: forse perché era un segno che con
quel posto non si conciliava troppo, forse per qualche altro motivo, il
giovane si ritrovò, nudo e con il librone nero in mano, in cima al pizzo
d’Arnasca (così viene chiamato in val Codera il pizzo Ligoncio), proprio
sul ciglio dell’impressionante parete liscia che precipita nella valle
omonima. Siccome conosceva bene quelle montagne, riuscì a scendere a
valle, dove incontrò due donne che gli offrirono una camicia ed un paio
di calze, purché gli consentisse di cancellare il loro nome dal libro.
Allora capì tutto: la sala misteriosa era un ritrovo di streghe e
stregoni, presieduto dal diavolo, ed allora corse dal Vescovo di Como per
denunciare i malefici della valle. Questi, nella cattedrale, lesse
pubblicamente i nomi segnati sul libro. Ogni volta che un nome veniva
pronunciato, la persona corrispondente appariva prodigiosamente. Streghe
e stregoni vennero così catturati e mandati al rogo. Un giorno, mentre si recava a trovarla, si imbattè in una volte
misteriosa e, seguendola, si accorse che entrava proprio nella casa della
fidanzata. Sbirciando, vide che questa e la madre, vestite della festa,
ungevano tempie, polsi e caviglie, pronunciando poi la formula “Tre ur
andà, tre ur a sta e tre ur a venì” e volando via attraverso la cappa del
camino. Preso dalla curiosità, pronunciò anche lui la formula, ma,
essendo furbo, apportò qualche modifica e disse “Un ur andà, un ur a sta
e un ur a venì”. Si ritrovò, così, in un grande salone, nel quale erano
riunite molte persone, anche morte, mentre un misterioso individuo, dalle
gambe caprine, scriveva su un librone il nome dei presenti. Lui tracciò
sul librone una croce, perché non sapeva scrivere, ed allora accadde
qualcosa di ancora più incredibile: forse perché era un segno che con
quel posto non si conciliava troppo, forse per qualche altro motivo, il
giovane si ritrovò, nudo e con il librone nero in mano, in cima al pizzo
d’Arnasca (così viene chiamato in val Codera il pizzo Ligoncio), proprio
sul ciglio dell’impressionante parete liscia che precipita nella valle
omonima. Siccome conosceva bene quelle montagne, riuscì a scendere a
valle, dove incontrò due donne che gli offrirono una camicia ed un paio
di calze, purché gli consentisse di cancellare il loro nome dal libro.
Allora capì tutto: la sala misteriosa era un ritrovo di streghe e
stregoni, presieduto dal diavolo, ed allora corse dal Vescovo di Como per
denunciare i malefici della valle. Questi, nella cattedrale, lesse
pubblicamente i nomi segnati sul libro. Ogni volta che un nome veniva
pronunciato, la persona corrispondente appariva prodigiosamente. Streghe
e stregoni vennero così catturati e mandati al rogo.
 Altre storie si raccontano sulle stregonerie
della Val Codera. Una di queste parla di un gatto nero che tenta di
aggredire un giovane che saliva a Codera per trovare la fidanzata: il
giovane gli taglia una zampa, che si trasforma prodigiosamente in una
mano con una fede al dito. Appena giunto in paese, si reca poi da una
donna che cerca di lui: entrato in casa, ode il suo lamento, vede un
moncone al posto della mano sinistra e capisce che il gatto era lei, e
che si trattava di una strega. Ed allora se ne esce con una frase
lapidaria: “Se eravate voi e non siete morta, morirete”. Altre storie si raccontano sulle stregonerie
della Val Codera. Una di queste parla di un gatto nero che tenta di
aggredire un giovane che saliva a Codera per trovare la fidanzata: il
giovane gli taglia una zampa, che si trasforma prodigiosamente in una
mano con una fede al dito. Appena giunto in paese, si reca poi da una
donna che cerca di lui: entrato in casa, ode il suo lamento, vede un
moncone al posto della mano sinistra e capisce che il gatto era lei, e
che si trattava di una strega. Ed allora se ne esce con una frase
lapidaria: “Se eravate voi e non siete morta, morirete”.
La gente della
valle sapeva che spiriti ed esseri malefici potevano scatenare il loro
potere dal suono dell’Ave Maria, alle sei di sera, fino ai primi
rintocchi del mattino (è un detto diffuso, in provincia di Sondrio, “suna
l’Ave Maria, gira la stria”, cioè al suono dell’Ave Maria la strega si
mette a girare). Ma il suono di questa campana, la Bàrbula, poteva anche
salvare dagli spiriti, quando suonava alle sei di mattina, ponendo fine
al tempo loro concesso per insidiare i viandanti. Si racconta che una
volta, in particolare, la Bàrbula salvò una donna che era stata costretta
a tornare di notte a Codera dopo avere acquistato una medicina a Novate.
Incontrò ad Avedèe, località dalla quale si comincia a vedere la valle,
quattro uomini con una lanterna, proprio mentre udiva il rintocco
dell’Ave Maria. Erano spiriti, e le dissero che se non fosse suonata la
campana, l’avrebbero portata via con sé.
I luoghi legati a queste
leggende (raccolte, insieme a molte altre, nel volume “C’era una volta”,
edito nel 1994 a cura del comune di Prata Camportaccio) possono essere
meta di una bella escursione (rigorosamente diurna!) che descrive un
elegante anello. Raggiungiamo, dunque, il parcheggio di Mezzolpiano (m.
326), frazione di Novate Mezzola, dove parte una mulattiera comoda e ben
curata, che si inerpica sull’impressionante fianco sinistro (per chi
sale) della forra della Val Codera. Questo sentiero è, insieme con quello
gemello sul lato opposto della valle, l’unico accesso a questa importante
valle, il che la rende pressoché unica fra le grandi valli della
provincia di Sondrio.  Il primo centro abitato che si incontra salendo è quello di
Avedèe, a 790 metri. Poco oltre, la valle comincia a mostrarsi
all’escursionista: appare anche Codera, il suo centro principale. Per
raggiungere il paese bisogna però scendere di qualche decina di metri,
lambendo, quasi, il fianco granitico della montagna e sfruttando anche
due preziosissime gallerie paramassi (i massi sono, infatti, su tracciati
come questo la più grande minaccia). Si risale, infine, ad una
cappelletta che annuncia il paese, preceduto dal suo cimitero, posto
quasi di fronte alla laterale val Ladrogno. Il primo centro abitato che si incontra salendo è quello di
Avedèe, a 790 metri. Poco oltre, la valle comincia a mostrarsi
all’escursionista: appare anche Codera, il suo centro principale. Per
raggiungere il paese bisogna però scendere di qualche decina di metri,
lambendo, quasi, il fianco granitico della montagna e sfruttando anche
due preziosissime gallerie paramassi (i massi sono, infatti, su tracciati
come questo la più grande minaccia). Si risale, infine, ad una
cappelletta che annuncia il paese, preceduto dal suo cimitero, posto
quasi di fronte alla laterale val Ladrogno.
Codera (m. 850) ci
accoglie con la chiesa, dal caratteristico campanile. Sul sagrato un
possibile prezioso punto di appoggio, il rifugio La Locanda.
Sul lato opposto del paese, abitato tutto l’anno, si può raggiungere un
secondo prezioso punto di ristoro, l’Osteria Alpina. A
questo punto si può lasciare il sentiero principale, che, prima tappa del
Sentiero Roma, si
addentra nella valle, e scendere sulla destra, seguendo le indicazioni,
al ponte sul torrente Codera, piccolo capolavoro d’ingegneria, sospeso su
quaranta metri di vuoto. Subito dopo il ponte si incontra un bivio e si
prende a destra, raggiungendo ben presto l’impressionante forra terminale
della val Ladrogno, valicata da un secondo e non meno ardito ponte. Poi
si raggiunge un più tranquillo bosco di castagni: il sentiero, salendo,
conduce alle case di Cii (m. 851).
Oltre Cii, il
sentiero prosegue nella salita, con traccia meno evidente, ma non lo si
può perdere: alla fine si congiunge con il Tracciolino, che, con un
tracciato pungo più di dieci chilometri, spesso intagliato nella viva
roccia, unisce la Val Codera alla Val dei Ratti, partendo dalla presa
d’acqua della Sondel poco sopra Codera e raggiungendo la diga sotto
Càsten. Il tracciolino valica il vallone della val Grande, entrando poi
in un bel bosco, sul grande dosso di Cola. 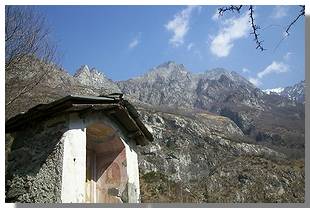 Qui viene tagliato da un sentiero che,
percorso in salita (sulla sinistra), conduce a Cola (m. 1018). La salita
all’abitato di Cola è uno sprofondare nel grembo del tempo. Qui il
silenzio è rotto solo dallo scampanìo delle capre. Il dosso termina alle
pendici rocciose che salgono alla punta Redescala (m. 2304), che nasconde
il Sasso Manduino. Qui viene tagliato da un sentiero che,
percorso in salita (sulla sinistra), conduce a Cola (m. 1018). La salita
all’abitato di Cola è uno sprofondare nel grembo del tempo. Qui il
silenzio è rotto solo dallo scampanìo delle capre. Il dosso termina alle
pendici rocciose che salgono alla punta Redescala (m. 2304), che nasconde
il Sasso Manduino.
Se, tornati al
tracciolino, lo si lascia subito per seguire il medesimo sentiero, ma in
direzione opposta, cioè scendendo verso destra, si incontra una
cappelletta, posta, come molte altre, a protezione del viandante che si
accinge ad affrontare luoghi insidiosi. Bisogna, infatti, calarsi nel
pauroso cuore del vallone di Revelaso, dove massi ciclopici sembrano dire
che questo non è posto per uomini. Sul lato opposto, il sentiero supera
un punto molto esposto (massima attenzione!), prima di condurre a luoghi
più tranquilli, fino a San Giorgio di Cola (m. 748), paese di cavatori di
granito, gentile e sorprendente isola bucolica in un mare di forre e
precipizi. Dal belvedere ottima è la vista sul lago di Mezzola. Questi
luoghi, come testimonia un avello celtico nei pressi del cimitero, hanno
visto da tempo assai antico la mano operosa dell’uomo. Se si sale alle
spalle del paese e si supera il cimitero ci si ricongiunge, seguendo le
indicazioni, verso il tracciolino.
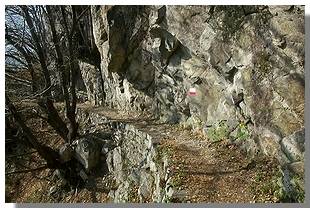 Per chiudere l’anello, però, bisogna procedere in direzione
opposta, imboccando un’ardita mulattiera che aggira, sulla destra, la
cima dello sperone roccioso su cui poggia il paese, si porta sul lato
opposto e scende sul suo fianco aspro e selvaggio. Anche qui la montagna
incombe sul viandante, senza però farsi mai veramente minacciosa.
Superato un ultimo tratto in un rado bosco, si giunge al termine della
mulattiera, e si scende, per una strada sterrata, a Campo di Novate, dove
una comoda strada ci riporta al parcheggio di Mezzolpiano, dopo circa 5
ore di cammino, necessarie per superare un dislivello approssimativo di
900 metri. Per chiudere l’anello, però, bisogna procedere in direzione
opposta, imboccando un’ardita mulattiera che aggira, sulla destra, la
cima dello sperone roccioso su cui poggia il paese, si porta sul lato
opposto e scende sul suo fianco aspro e selvaggio. Anche qui la montagna
incombe sul viandante, senza però farsi mai veramente minacciosa.
Superato un ultimo tratto in un rado bosco, si giunge al termine della
mulattiera, e si scende, per una strada sterrata, a Campo di Novate, dove
una comoda strada ci riporta al parcheggio di Mezzolpiano, dopo circa 5
ore di cammino, necessarie per superare un dislivello approssimativo di
900 metri.
|
|
|
|
|
|
|
|